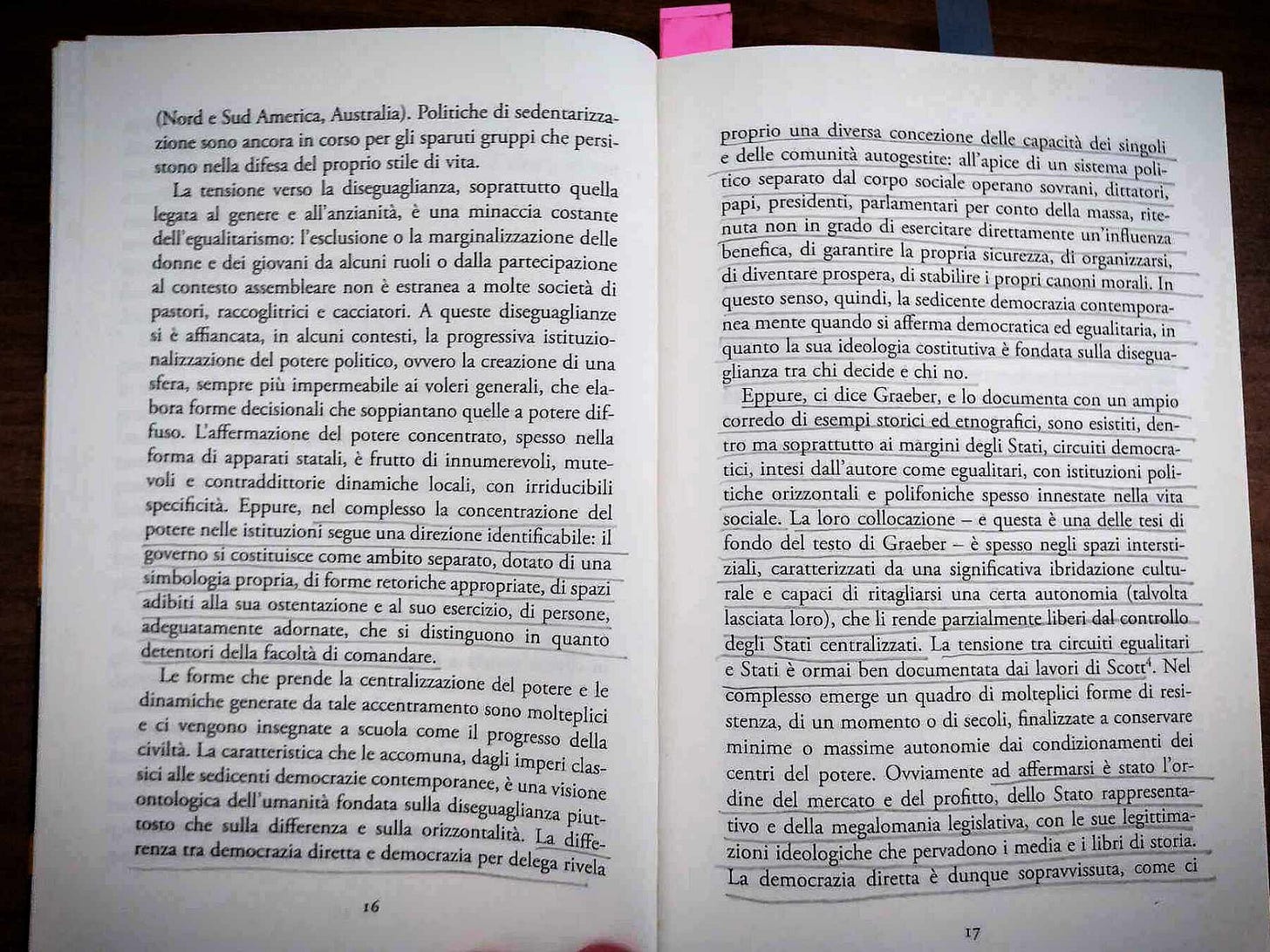Prontuario per una critica della democrazia atlantica [Achtung Disertoren! #15]
Il mondo atlantico vende i suoi valori e la sua Democrazia al mondo. Ma se questi non fossero davvero nati in Occidente? Appunti da “Critica della democrazia occidentale” di David Graeber (pt.1)
Gabriel García Marquez già nel 1991 la chiama “fondamentalismo democratico”: è quell’ideologia che indica nella democrazia liberal-parlamentare il migliore dei sistemi possibili, quel modo di intendere che vede la Storia del mondo come uno scontro perenne tra il “noi-buono” e l’”altro-cattivo” che, proprio per il suo ruolo, è necessario democratizzare, educare ai “nostri” valori che sono – per definizione – quelli giusti. La storia del blocco atlantico può essere scritta seguendo questa linea narrativa, partendo da Cristoforo Colombo per arrivare fino alla guerra in Ucraina e al tentativo di colonizzare il Medio Oriente sotto la bandiera israeliana del 2024. Ne abbiamo già parlato, ma la Critica alla democrazia occidentale1 di David Graeber ci aiuta a chiarire meglio la questione.
Dello scontro tra cosmesi e insurgenza del Principio democratico
Scrive Graeber (p.74) che già tra il 1830 ed il 1860, «nel periodo in cui i poteri europei cominciarono a ritenersi “democratici”», iniziano anche a «perseguire una politica intenzionalmente finalizzata a sostenere élites reazionarie», che esattamente come le omologhe discendenti odierne pongono l’obiettivo nel contrastare e reprimere qualunque idea, progetto, legge o riforma di natura realmente democratica, basata cioè su quella Democrazia realmente espressione del popolo – e che in tempi più moderni viene definita insurgente - che non si limita al mero gioco, o giogo, elettorale. A riprova della tesi Graeber porta l’atteggiamento tenuto in quegli anni dalla Gran Bretagna:
contro la ribellione del governatore d’Egitto Muhammad Ali Pascià al Trattato di Balta Liman del 1838, un accordo di (finto) libero scambio che permette all’imprenditoria britannica di entrare senza vincoli in vari mercati commerciali dell’Impero Ottomano che, nel percorso opposto, si trova invece bloccato da politiche di forte protezionismo adottate dalla Corona inglese per tutelare, ad esempio, il proprio mercato agricolo. Una politica che forse non è troppo distante dal “friend shoring” adottato in questi anni all’interno del blocco atlantico. Grazie alla clausola della “nazione più favorita”2, presente nel Trattato, Londra riesce ad ostacolare proprio le politiche commerciali egiziane
in sostegno dell’Impero Quing-Manciú contro la “ribellione Taiping“ (1851-1864), una guerra civile contro l’autoproclamato Stato indipendente del Tianjing, nato con la istituzionalizzazione della setta religiosa – e gruppo paramilitare – “Società degli adoratori di dio”, che predica il monoteismo, l’egualitarismo, la collettivizzazione dei beni ed il ritorno alla Cina “sovrana” contro un Potere, giudicato corrotto, che ha però strette alleanze internazionali, tra cui quella con la Gran Bretagna: saranno tali rapporti a permettere la vittoria dell’Impero con la decisiva battaglia di Shangai, città che i Taiping provano a prendere – dopo Nanchino, che diventa Capitale dello Stato “ribelle” – in quanto fondamentale porto commerciali con le potenze internazionali
«In entrambi i casi», scrive Graeber:
i britannici cercarono dapprima una scusa qualsiasi per sferrare un attacco contro uno dei maggiori Anciens Régimes asiatici; dopo averlo sconfitto militarmente, la mossa successiva fu di imporgli un trattato commerciale vantaggioso per loro e infine, con una sterzata improvvisa appoggiarono quello stesso regime contro i ribelli politicizzati, palesemente più vicini ai loro pretesi «valori occidentali» del regime che adesso difendevano. Nel primo caso, infatti, si trattava di una rivolta che mirava a trasformare l’Egitto in un moderno Stato-nazione, nel secondo di un movimento egualitario cristiano che reclamava la fratellanza universale
La conclusione del discorso ci riporta dalla Gran Bretagna del 1800 all’Europa-Fortezza – e in generale al progetto di “società autoritaria” – del 2024: un contesto sociale, economico e politico che, attraverso la leva repressiva e militare, sta rendendo «inevitabili i regimi autoritari», restringendo lo spazio per i movimento davvero democratici. Per informazioni rivolgersi a chiunque abbia assistito o partecipato ad una manifestazione politica in cui le forze di polizia si siano presentate in assetto antisommossa.
Se vince l’”ambiguità” dello sguardo occidentale
In questo arco di tempo, sostiene Graeber (p.77), è stato commesso un “errore metodologico” nel ricostruire la biografia della Democrazia: quando gli Stati iniziano a confrontarsi – e ancor più a scontrarsi – ai tempi degli imperi, delle monarchie e delle colonie, ognuna di queste entità ha bisogno di una vera e propria operazione di marketing, un processo di autonarrazione che la inquadri nel ruolo dei “buoni”, obbligando chi all’epoca viene pagato per narrare le gesta di re, imperatori e governanti all’agiografia contro il mondo “altro” e, per definizione “barbaro”. Un mondo a cui, ieri come oggi, offrire “libertà”, “diritti umani” ed “eguaglianza per tutti” si vende meglio che esportare “sfruttamento”, “diseguaglianza” e una società basata sul privilegio di una parte dei suoi membri.
Graeber parla di «ambiguità dello sguardo occidentale» (p.77), una visione etnocentrica e “paracoloniale” che pone il Potere occidentale come unico custode – autoproclamato – di uno specifico set di valori e cancella tutta la Storia che si è sviluppata nei territori “altri“ prima dell’arrivo dell’occhio occidentale: quando politici e giornalisti fissano la nascita della guerra in Ucraina al 24 febbraio 2022, oppure lo «sterminio»3 israeliano della popolazione palestinese come risultato degli «attacchi» di Hamas del 7 ottobre 20234 applicano in maniera più o meno (in)consapevole tale «ambiguità».
È chiaro come uno “sguardo”5 di questo tipo, che stabilisce l’inizio della Storia dal momento dell’arrivo occidentale, non solo cancella tutto ciò che ha portato a quel momento esatto, ma permette al narratore di definire concetti basilari come “buono/cattivo” secondo la sua convenienza, il suo bagaglio di ideologie, valori e soprattutto interessi economici. I casi delle elezioni 2024 in Venezuela e Georgia – quest’ultima riproposizione della sceneggiatura usata in Ucraina tra il 2014 ed il 2022 – sostengono tale tesi. La cronaca dei fatti diventa così, nel senso più letterale del termine, colonialismo informativo.
I valori occidentali? Beh, non sono proprio “occidentali”…
Lo sguardo etnocentrico porta ad un altro, fondamentale, “errore metodologico”: credere che i valori “occidentali” siano davvero nati in Occidente. Anzi, Graeber evidenzia come questi siano addirittura indipendenti dagli Stati-nazione, perché nati all’interno di un «complesso spazio interculturale» (p.76) ed assimilati solo in un secondo momento dal Potere “dello Stato”, che nelle sue fasi primordiali ha bisogno di legittimarsi davanti a sudditi e potentati vari.
Nella ricostruzione storica che ne dà l’antropologo statunitense, i valori occidentali sono nati in «zone di improvvisazione culturale», formazioni fuori dal controllo dello Stato nate dalla libera associazione di persone, provenienti da tradizioni diverse, che trovano - «sono costrette» a trovare, sottolinea Graeber – un terreno comune con cui rapportarsi con gli altri, interni o esterni alla nuova comunità di appartenenza. Nei fatti è la costituzione di primordiali comunità anarchiste.
Gli studiosi e i narratori dei secoli scorsi, continua Graeber, non avrebbero fatto altro che citare i primi testimoni di questa statalizzazione, cristallizzando così una situazione che ha etnicizzato la costruzione delle ideologie e dei valori delle diverse comunità. L’invenzione dello Stato-nazione - o il “problema“ dello Stato-nazione, come lo definisco qui su Inchiostro Politico - porta infatti 2 modifiche sociali che non solo lo sguardo anarchico definisce “antidemocratiche”:
la gerarchizzazione dei rapporti tra gruppi sociali, che porta ad instaurare società basate sulla disuguaglianza e sulla diversa redistribuzione dei poteri tra le diverse istanze che la compongono
la presenza di meccanismi “sistematici” di coercizione, propedeutica alla tenuta del Potere statalizzato, necessari ad imporre le decisioni prese dal gruppo al comando della società e a cancellare anche il più piccolo spazio di dissenso popolare che non sia controllabile dall’”Autorità”
È la cooptazione di questi “nuclei meticci” all’interno dell’organizzazione verticale della società a trasformare ed ascrivere allo “Stato” pratiche democratiche nate al di fuori o addirittura contro l’idea di un equilibrio di rapporti così gerarchizzato, in una operazione che – dalla forma monarchica e nobiliare fino al governo repubblicano – serve al Potere costituito per disinnescare possibili focolai di conflitto.
Caso studio: Kaianere’ko:wa goes to Washington
Tra le prime esperienze che traslano la Democrazia e i suoi valori dal piano teorico all’applicazione “occidentale” pratica c’è la Kaianere’ko:wa (“Grande legge di Pace”, in italiano), la Costituzione orale – ma composta da 117 articoli – adottata dall’Haudenosaunee, la “Confederazione Irochese” nota anche come “Lega delle 6 nazioni” sotto la quale, nel 15706, si riuniscono 5 tribù native americane stanziate nella regione dei Grandi Laghi, tra Stati Uniti e Canada: Kayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga e Seneca e a cui nel 1722 si aggiungono i Tuscarora, che dal territorio oggi identificato come Carolina del Nord sono costretti a migrare verso nord a causa dei conflitti con i colonizzatori europei, che in quel periodo sono soprattutto britannici e francesi.
La Confederazione riproduce l’organizzazione interna delle Nazioni-tribù che la compongono, basate su un sistema clanico, matrilineare e matriarcale: le donne ricoprono un ruolo fondamentale in molti aspetti, dalla trasmissione della posizione sociale ai figli alla gestione degli equilibri tra le singole Nazioni, fino al potere di veto nei “Consigli di Fuoco”, assemblee interne confederali in cui si delibera secondo una sorta di “bicameralismo perfetto”: ogni Consiglio è composto da 3 gruppi, di cui 2 “dibattenti” – divisi a schema fisso Mohawk-Seneca e Oneyda-Cayuga – con gli Onondaga a fare da Guardiano-arbitro, pronto a interviene in caso di stallo. Ogni decisione diventa però legge solo una volta approvata dall’intero popolo.
Riprendendo gli studi dello storico irochese Donald Andrew Grinde jr, Graeber riporta (p. 78) come la “Grande legge di Pace” abbia influenzato in più parti la Costituzione degli Stati Uniti, soprattutto grazie all’attività di Benjamin Franklin, che propone alle 13 Colonie fondatrici di costituirsi in Federazione proprio sul modello irochese, del quale osservava con interesse tanto la tutela dei diritti individuali quanto la separazione dei poteri. Questa influenza – evidente anche nei simboli, a partire dall’aquila e dalle 6 frecce – dal 1988 è ufficializzata dallo stesso governo di Washington attraverso la Concurrent Resolution 551.
Dalla cultura irochese, però, gli Stati Uniti sembrano aver assimilato anche un’altra tradizione: quando la “Grande Pace” veniva proposta ad una Nazione straniera – una tribù che ancora non faceva parte della Confederazione o un Paese colonizzatore – e questa rifiutava, le 6 Nazioni erano obbligate a muovere guerra fino alla conquista della tribù “ribelle”. Quale valore “occidentale”, o ancora meglio “atlantico”, ricorda?
Pirati&proletari, semi (nascosti) di democrazia “occidentale”
La democrazia che oggi codifichiamo come “occidentale”, fatta di parlamenti, partiti e momenti elettorali è nata anche in luoghi che il Potere occidentale taccia di “terrorismo” e “criminalità”, come evidenzia Graeber citando lo storico John Markoff, tra i più importanti studiosi della democrazia contemporanea e autore dello studio Where and When Democracy Invented7. La democrazia “del buon governo” zapatista creata nel 1994 dall’Esercito di Liberazione nella regione messicana del Chiapas o il confederalismo democratico kurdo, ideato da Abdullah Öcalan sulle idee anarchiche del sociologo e filosofo Murray Bookchin8, sono in tal senso esempi perfetti dai tempi moderni.

Markoff porta un esempio più antico e inaspettato dal lettore medio: il vascello pirata e la sua organizzazione interna, basata su quel “codice piratesco” – adottato per primo da Bartolomeu il Portoghese a partire dalla seconda metà del ‘600 – che diventava legge solo all’interno della comunità-ciurma e, anche per questo, applicata senza il controllo di una autorità terza precostituita. Solo accettando il codice si poteva si poteva far parte della comunità piratesca: all’auto-organizzazione si aggiunge così la libera adesione, non è un caso che la società democratica per antonomasia sia espressa perfettamente nell’anarchia, di cui tali principi sono pilastri. Che quella piratesca sia una democrazia anarchista – e dunque l’unica, vera, esperienza possibile di democratica reale – lo dimostra proprio il codice, che tra le altre prevede:
diritto di voto per tutti gli uomini appartenenti alla ciurma, che eleggono il capitano e gli ufficiali secondo il principio dello stesso peso per ogni voto
tranne che nei momenti di combattimento dove è primus inter pares, il capitano non ha alcun privilegio né vantaggio se non in termini di redistribuzione del bottino, può comunque essere sfiduciato in qualsiasi momento per codardia, crudeltà o qualunque altro motivo la ciurma ritenga legittimo
sono vietati gioco d’azzardo e risse a bordo della nave
l’elezione degli ufficiali, soprattutto del quartiermastro – secondo nell’ordine gerarchico – serve come bilanciamento dei poteri del capitano, così come l’elezione del Consiglio di bordo
nei contratti di pirateria, discussi sia a livello individuale che collettivo, oltre a fissare le quote di spartizione del bottino prevedono indennità per infortuni e menomazioni sul lavoro, il cui importo varia a seconda della gravità dell’infortunio stesso
ogni decisione viene presa in modo collettivo, alla presenza dell’intera ciurma
La comunità-ciurma è, inoltre, espressione archetipica di una società profondamente meticcia, per estrazione sociale tanto quanto per nazionalità e competenze che ogni membro è in grado di offrire: quella guidata da Samuel “Black Sam” Bellamy (1689-1717), conosciuto come “il Principe dei pirati”, era ad esempio composta da «britannici, francesi, olandesi, spagnoli, svedesi, nativi americani, afroamericani e due dozzine di africani liberati da una nave schiavista», riporta Graeber basandosi su uno studio dello storico Marcus Rediker9. Questo meticciato si evolverà, tra il 17° ed il 19° secolo, con l’incontro nei porti oceanici con le fasce più marginalizzate della società dell’epoca, nel cosiddetto “proletariato atlantico”, una delle prime forme moderne di rivendicazione organizzata di diritti, libertà e istanze che oggi consideriamo “universali”.
”Solo il popolo salva il popolo”
«D’altronde, le pratiche democratiche tendono a essere elaborate in luoghi distanti da quelli frequentati dai costituzionalisti» scrive Graeber (p. 83) riecheggiando, forse in modo inconsapevole, quella considerazione che già Piero Calamandrei10 espone nel 1955, durante una conferenza universitaria tenuta a Milano a proposito dei “luoghi partigiani” e popolari in cui è nata davvero quella Costituzione Italiana che
non è una carta morta, ma il testamento di 100.000 morti per la libertà. Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata la nostra Costituzione
e, di conseguenza è nata quell’Italia repubblicana che, almeno sulla carta, nasce antifascista e democratica. Anche il proletariato atlantico di cui parlano Rediker e Graeber è, nei fatti, una forma di democrazia “partigiana” – e insurgente – con le prime lotte per un lavoro più equo e sicuro che si mescolano alle istanze antischiaviste, alle battaglie per i diritti delle donne, l’uguaglianza e l’estensione del diritto di voto: così gli schiavi neri si trovano a lottare fianco a fianco con i lavoratori sfruttati dei centri urbani, con «liberti, marinai, prostitute, rinnegati, antinomiani11» in proteste che uniscono «piantagioni delle Americhe, alle campagne irlandesi, alle navi nell’Atlantico e alle strade di Londra».
Questa unione, che in realtà è un seme di quella classe proletaria che si formerà solo più tardi, testimonia ciò che Calamandrei sosteneva quando la Democrazia in Europa fu condannata a morte: cioè che qualunque processo democratico non può che nascere “dal basso”, tra e per la gente. Non è un privilegio concesso dall’incontro tra politica dei partiti e agenzie di marketing. Di conseguenza, è solo un popolo pienamente istruito e responsabilizzato a poter gestire la Democrazia nel suo senso più pieno, diretto e orizzontale e a dover rifuggire la sua deriva esportabile, soprattutto se ciò avviene manu militari.
Anzi, come ricostruisce Graeber (p.99) l’Autorità che verticalizza il processo di decisione pubblica nasce proprio per sopprimere «le forme locali di autogoverno e di processo decisionale positivo». Se la sovranità del popolo è alla sua massima espansione quando è orizzontale e paritaria - «senza concentrazioni di ricchezza», sottolinea l’antropologo anarchico (p.82) – è chiaro come pompare rapporti gerarchici in un sistema del genere rende «sedentaria» la popolazione, rinchiudendola entro confini geografici, economici e sociali e fornendo ad una parte minoritaria «significative risorse da amministrare». È così, nel passaggio tra Democrazia e democratura, che si creano disuguaglianza, conflitto sociale e guerre.
L’Unione Europea militarista e militarizzata che si conferma nelle elezioni del 2024 – un sistema di Potere che nulla ha più a che fare con l’idea antifascista sognata a Ventotene - mira esattamente a questo obiettivo? Non è un caso che le forme più dinamiche di ritorno alla democrazia vengano oggi represse da quella stessa Autorità, come ben dimostrano esperienze come la democrazia zapatista del buon governo in Chiapas, il confederalismo democratico messo in pratica tra Kurdistan, Rojava e Shengal o movimenti di lotta popolare contro le Grandi Opere Inutili come i NoTav in Val di Susa. Perché, come di recente è stato ricordato dalla cittadinanza valenciana, colpita dalla “Dana”: «solo il popolo salva il popolo». Un progetto di società la cui applicazione politica, sociale ed economica che l’Autorità non può lasciar diffondere, pena la sua stessa esistenza.
Questo articolo fa parte della serie "Achtung Disertoren!", l'approfondimento di Inchiostro Politico su antimilitarismo, guerra e diserzione sullo sfondo della guerra in Ucraina. Trovi l’intero approfondimento nell’apposita sezione in homepage. I grassetti nelle citazioni sono miei, dove non diversamente specificato.
Note:
David Graeber, “There never was a West, or Democracy emerges from the spaces in between”, Chico (California), AkPress, 2019. In italiano: “Critica alla democrazia occidentale”, traduzione Alberto Prunetti, Milano, 2012, p.74. David Graeber è stato un antropologo, dichiaratamente anarchico, noto al grande pubblico soprattutto per essere tra gli intellettuali di riferimento del movimento Occupy
Clausola contenuta nei trattati internazionali con la quale i Paesi contraenti si impegnano a definire le condizioni più favorevoli, da concedersi vicendevolmente, in una specifica materia o nei confronti di uno specifico Paese terzo
Di «sterminio» del popolo palestinese parla un rapporto dell’Onu – realizzato da una specifica commissione d’inchiesta guidata da Navanethem (Navi) Pillay – che accusa il blocco di potere politico-militare israeliano di aver risposto all’operazione terroristico-criminale di Hamas del 7 ottobre 2023, poi smontata da un’inchiesta del giornale Haaretz sulla “Direttiva Annibale”, compiendo «crimini di guerra», «crimini contro l’umanità», «violazioni del diritto umanitario internazionale degli standard sui diritti umani», tra cui «attacchi deliberati contro civili e strutture civili», l’uso della fame come strumento di guerra, lo sfollamento forzato, la persecuzione anche di genere, forme varie di violenza e, appunto, come dichiara Pillay al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani , «sterminio di massa»
Come li definisce Francesca Albanese, dal 2022 Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati nel suo libro "J'accuse. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra", Milano, Edizioni Fuoriscena, 2023
Da intendersi nel senso dell’”habitus” teorizzato dal sociologo e antropologo Pierre Bourdieau, come sistema di principi e strutture da cui origina il modo – definito come l’”abitudine” – in cui si guarda e reagisce al mondo circostante
Altre fonti retrodatano la fondazione della Confederazione in un periodo compreso tra il 1090 ed il 1150
Lo studio è contenuto in “Comparative Studies in Society and History”, Cambridge, Cambridge University Press., 1999, pp.660-690
Per approfondire puoi partire da: Murray Bookchin, “Per una società ecologica”, Milano, Elèuthera, 2021. Qui una riflessione-sintesi della redazione di InfoAut
Markus Rediker, “Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age”, Boston, Beacon Press, 2004, p.53. In italiano: “Canaglie di tutto il mondo: l’epoca d’oro della pirateria”, Milano, Eléuthera, 2016, Ripreso da David Graeber, op.cit., p.85
Giurista, docente – e per qualche giorno rettore - all’Università di Firenze nell’Italia appena uscita dall’esperienza bellica e fascista, è tra i padri fondatori della Repubblica, partecipando come capogruppo del Partito d’Azione all’Assemblea Costituente
Osservanti dell’antinomismo, dottrina che permette ai membri di una particolare comunità, solitamente religiosa, di non osservare leggi contrarie alle loro credenze morali e religiosi